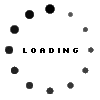Prefazione alla VI Edizione:
La foto, l’inchiesta, i capelli di Sergio
di Luca Telese
Intanto quella foto. Se si è tramandata una memoria di Sergio Ramelli, e se poi questo nome (e la sua vicenda) hanno potuto sorvolare trent’anni di storia italiana, attraversare la nube di oblio degli anni di piombo e rompere le barriere del pregiudizio e delle appartenenze, è soprattutto per quella foto: il ragazzo con i capelli lunghi, con lo sguardo innocente, gli occhi castani e luminosi. E poi la brutale ferocia di un omicidio celebrato a colpi di chiave inglese, con l’aggravante della premeditazione e del delitto su committenza; un festino di sangue e morte allestito con scrupolo da ragionieri, da una banda di studenti di medicina animati da squallide velleità di guerriglia politica.
E poi questo libro. La prima edizione di “Sergio Ramelli. Una storia che fa ancora paura”, era uscita nel 1997 come un documento semi-clandestino, nato come testimonianza di comunità di parte, ed era invece destinata a suscitare uno dei più grandi successi di vendita al di fuori dei circuiti ufficiali che si ricordi in questo Paese. Cinque edizioni, 16 mila copie vendute capillarmente, sotterraneamente, banchetto per banchetto. E poi una lista di presentazioni e un itinerario in giro per l’Italia nel nome di Sergio che possono essere comparati solo alle tappe della tournée di qualche pop star, o a un viaggio elettorale. Invece, non si trattava né della prima, né della seconda ipotesi. Gli autori che firmavano (e firmano) quel saggio erano cinque, e perfettamente sconosciuti al grande pubblico. Il libro se l’erano stampati praticamente da soli. Per di più, quando era uscito, non ne aveva scritto nessuno: non una recensione, non un trafiletto, nemmeno una segnalazione sui grandi giornali di opinione.
Ma tutte queste cose messe insieme, per quanto interessanti, non basterebbero a giustificare oggi una ristampa, se non ci fosse un elemento in più, e decisivo: l’inchiesta. Ecco, l’inchiesta, in Italia, nel panorama troppo spesso vaniloquente e un po’ gaglioffo della stampa italiana, è un genere ormai estinto o inflazionato. Accade ogni tanto nei giornali che un direttore dica: “Ci vorrebbe un’inchiesta”. E che poi questi apprezzabili propositi regolarmente si esauriscano prima di arrivare in pagina, che le inchieste commissionate non trovino mai posto quando vengono scritte, che spesso abortiscano dopo la prima puntata, magari per censura o autocensura, il più delle volte semplicemente per incuria. Il motivo per cui in Italia tutti vorrebbero le inchieste e poi nessuno le pubblica è semplice: richiedono tempo, pazienza, motivazione di chi le realizza e di chi le commissiona. E siccome i giornali tendono sempre di più a impolverirsi e a “deskizzarsi”, a tramutarsi in miniere di scavatori anonimi o di impaginatori diligenti, magari sotto l’impulso di qualche tagliatore di teste che vuol far quadrare i bilanci, va a finire quasi sempre che le cose stanno così: quando un giovane entra per la prima volta dentro un quotidiano gli chiedono il contrario di quello che vorrebbe fare, e quando arriva a potersi permettere di fare quel che vuole, si è già arreso o demotivato alla resistenza immane di quel che c’è già. Ci sono ovviamente delle eccezioni, spesso collocate alla sinistra e alla destra del panorama editoriale, talvolta persino al centro, se si tratta di qualche questione economica. Non a caso, nei rari casi in cui le inchieste vanno in pagina, accadono piccoli e grandi sfracelli. Tina Merlin anticipò il disastro del Vajont sulle colonne de l’Unità, Il Giornale con Affittopoli arrivò a “persuadere” (eufemismo) Massimo D’Alema a comparsi una casa e ad abbandonare il suo affitto pubblico di via Musolino. Per fare un’inchiesta sulla scomparsa di Enrico Mattei ci ha rimesso le penne un giornalista come Mauro De Mauro, per denunciare i misteri degli appalti di Punta Raisi è saltato sul tritolo Peppino Impastato.Persino una inchiesta recentissima e non certo virtuosa, come quella di Enrico Deaglio sui cosiddetti “brogli” produsse ciò che il centrodestra non aveva ottenuto in tre mesi di proteste, dopo le elezioni del 2006: il ricompiuto dei voti. Quando poi L’Espresso ha messo piede dentro uno dei più paleolitici policlinici italiani, si sono scomodati ministri e ispettori per accertamenti che, fino a quel momento, nessuno aveva ritenuto necessario ordinare.
Se ricordo tutto questo, è perché questi “non professionisti” (il solo Giraudo era un giornalista, ex vicedirettore del “Candido” negli anni Settanta) che nel 1997 si mettono a scavare sul “Caso Ramelli” in realtà forniscono una lezione che sarebbe utile a molti. Sono di destra, certo, e sono motivati da un desiderio di battaglia memoriale: ma la loro diventa una testimonianza civile, prima ancora che politica. E poi sono terribilmente rigorosi. Non si perdono in mille fronzoli, non inseguono la bella pagina, non fanno calligrafia, lavorano di olio di gomito e di archivio, setacciano le emeroteche, raccolgono le testimonianze dirette. Sono di parte? Certo. Ma adottano, per la prima volta, un metodo e una cifra scientifica: il loro lavoro è utile a chiunque voglia ripercorrere quel sentiero di storia italiana.
Quando, sei anni dopo, mi misi in testa di scrivere un libro che raccontasse le storie dei ventuno ragazzi di destra radicale e non, uccisi negli anni di piombo, l’unico su cui esistesse un lavoro di rigorosa ricostruzione documentaria, grazie a questo libro, era per l’appunto Sergio Ramelli. Ricordo che a una presentazione di “Cuori neri”, nel 2006, un giornalista non certo sospetto di simpatie per la storia missina come Gad Lerner chiese a Giraudo: «Non è che ne avresti una copia da mandarmi?». No, non ne possedeva più nemmeno una per sé, le aveva finite. Così è nata l’idea di questa ristampa. Perché la storia di Sergio ebbe il destino di trovarsi al crocevia di molte storie importanti, e continua a costituire una pietra miliare nella cronologia degli anni di piombo. Alcuni dei motivi sono già noti a chi ha già letto “Cuori neri”.
Il primo: il delitto Ramelli celebrò, come non era mai accaduto prima, la spersonalizzazione della vittima, la tragica e meccanica banalizzazione dell’omicidio politico. A uccidere Sergio non erano i suoi avversari politici diretti, ma un gruppo di studenti che apparteneva al servizio d’ordine di Avanguardia operaia. Il più “sfigato” dei servizi d’ordine dei gruppi extraparlamentari milanesi, va aggiunto, quello che, come ricordava lo stesso Lerner in un articolo del 1987, si era guadagnato il nomignolo malefico di “Brigata coniglio”. Ma questo stesso gruppo trovò nella morte di Sergio, come in quasi tutti i casi che avrei raccontato in “Cuori neri”, il proprio punto di non ritorno, un “delitto iniziatico”. I “Conigli” si fecero “idraulici” (per via delle chiavi inglesi che usavano come armi improprie) prima ancora che si chiudesse il coma di Ramelli: era più forte di te. Dopo che avevi ucciso la prima volta, la deriva della storia ti faceva fare il salto dall’amministrazione più o meno controllata della violenza di piazza, alla lotta armata e alle sue sanguinose approssimazioni.
Il secondo motivo: il caso Ramelli, era diventato , al pari di tanti altri delitti di quel tempo il romanzo di formazione di un frammento di classe dirigente, sia di destra che di sinistra. Tra gli avvocati del processo, che si celebrerà a dodici anni di distanza, troviamo su fronti avversi – tanto per fare tre nomi – un futuro deputato di An come Ignazio La Russa, un futuro deputato di Forza Italia come Gaetano Pecorella e un futuro deputato di Rifondazione comunista come Giuliano Pisapia. L’elenco potrebbe continuare con giornalisti, magistrati, politici e gli altri nomi li troverete nelle pagine del libro.
Terzo motivo: l’omicidio Ramelli era già un anello nella catena del sangue e diventava a sua volta il prologo di altri delitti: senza questo atroce coma senza ritorno, probabilmente, Milano si sarebbe potuta risparmiare una settimana di guerriglia urbana e due cadaveri che sono direttamente o indirettamente collegati al delitto. Claudio Varalli resta a terra durante uno scontro a fuoco nato dopo un volantinaggio che si celebrava nel nome di Ramelli (a cui per ironia della sorte prendeva parte Giraudo, ma non Antonio Braggion, l’uomo che colpì il militante di sinistra con la sua 7.65, mentre veniva assalito nella sua Mini). E sempre lungo il filo del sangue di quei giorni trova posto Giannino Zibecchi, investito da un camion dei carabinieri nei caroselli che seguono l’assalto di un corteo extraparlamentare alla federazione missina di via Mancini dopo la morte di Varalli.
Siccome il grosso dell’inchiesta l’avevano fatta Giraudo e i suoi coautori, quando si trattò di affrontare la storia di Sergio, mi ritrovai nella possibilità di inseguire altre piste. La prima, quella del rimorso, mi portò a incontrare il libro di Giorgio Mellitton (che cito ampiamente in “Cuori neri”) il professore di italiano di Sergio, che alla fine degli anni Ottanta era già un uomo tormentato dal senso di colpa per non aver fatto abbastanza, di non aver impedito l’omicidio del suo studente (come forse avrebbe potuto se avesse capito subito la gravità delle minacce a cui era stato sottoposto), raccontò la sua storia con un libro pieno di malinconico strazio e di particolari agghiaccianti. Su tutto basterebbe l’aneddoto raccontato dal professore, quello sulla sua collega che, con il corpo ancora caldo, commentava la morte di Sergio con lo stesso senso di pietas che avrebbe potuto rivelare il kapò in un lager: «Di fronte a una tazza di caffè, a voce alta perché gli altri sentissero – ricorda Mellitton nella sua memoria – la professoressa di lettere del triennio F disse: “E che importa, se dunque era un fascista?”». Non era sola: «Un’altra sua collega, del corso E esclamò con sgomento: “Sono cose più grandi noi”». E una terza, tanto per chiudere il quadretto tratteggiato da Mellitton, sospirò: «A Roma sono più forti neri, a Milano noi”».
Nella sua raggelante spietatezza, quest’ultimo commento rivelava un’altra verità: sotto la sovrastruttura degli odi ideologici, il delitto Ramelli, e tutti gli altri che negli anni Settanta hanno visto cadere i cuori rossi e neri, la vera “meglio gioventù” di questo Paese, erano incrostati con qualcosa che stava dentro le viscere di un paio di generazioni di italiani: un rancore atavico, cieco, irrazionale e per certi versi persino tribale. E’ una delle prime cose che ho imparato studiando quegli anni, e che ripeto in ogni posto d’Italia in cui mi invitano. Ma quando pronuncio queste parole, molto spesso, incontro qualche saettare di sguardi perplessi, magari la cifra di un sorriso. Eppure, con la stessa regolarità di un metronomo, ogni anno il rintocco di qualche tragedia di cronaca, dai processi alle rivelazioni, dalle guerriglie urbane al disvelamento dei piani di qualche manipolo di vecchi o nuovi brigatisti, ci spiega quanto quegli odi antichi siano ancora vivi, persistenti, e destinati a covare anche dopo che le fiamme sembrano estinte, come la brace sotto la cenere.
Ma questo libro è anche un giallo, virato di nero. A sei anni dalla sua uscita e a quasi venti dall’apertura della decisiva inchiesta sul delitto Ramelli, sono riuscito a parlare con il magistrato che è tra i protagonisti di queste pagine. Fu un magistrato indubitabilmente di sinistra come Guido Salvini, infatti, a scoperchiare l’abisso di questo delitto sepolto. E questo è anche un altro punto dirimente del caso Ramelli: il suo è uno dei pochissimi omicidi degli anni di piombo per cui si sono travati dei colpevoli. Dei colpevoli reoconfessi, che come dimostra questo libro, non per questo non vennero difesi al di là di ogni senso logico da alcuni dei loro ex compagni dell’epoca. Quando iniziò a celebrarsi il processo, infatti, qualcuno (in testa a tutti un partito che oggi non c’è più, Democrazia Proletaria, e un quotidiano, il Manifesto) provarono a dire che non si trattava di un processo legittimo, ma del tentativo di mettere sul banco degli accusati un’intera generazione, di una scellerata avventura revisionista celebrata per spirito di opportunismo o per compiacere la destra.
Argomentazioni che, come scoprirà chi legge questo libro, erano a dir poco risibili allora, e lo sono anche oggi. Dopo aver letto “Cuori neri”, Mario Capanna mi ha detto: «Vedi, posso affermare con orgoglio che nessuno dei ventuno delitti che racconti ha visto coinvolto qualcuno che proveniva dal mio Movimento studentesco. E questo perché noi, al contrario degli altri gruppi, avevamo ben chiaro il confine con la violenza». Ma anche ammesso che la statistica ipotizzata da Capanna fosse vera, allora perché difendere a spada tratta come dei martiri, degli imputati che ammettevano le proprie colpe? Fra di loro, per di più, ce n’era un altro, Marco Costa, che durante il dibattimento, quando ricordava come se fosse al presente l’atroce sequenza della sprangatura, si era spinto a
dire: «Ramelli capisce, si protegge la testa con le mani. Ha il viso coperto e posso colpirlo al viso. Ma temo di sfregiarlo, di spezzargli i denti. Gli tiro giù le mani e lo colpisco al capo con la chiave inglese». Ogni volta che rileggo questa deposizione penso a quei terribili minuti e sono attraversato da un moto di rabbia, per questo killer compassionevole che non vuole sfregiare ma preferisco uccidere. Eppure credo che in questa deposizione Costa fosse sincero, e dimostrasse inconsapevolmente quanto possa essere infinitesimale la distanza che in certi momenti del tempo e della storia separa un bravo ragazzo da un assassino: poco meno di un gesto. Durante lo stesso processo sempre Marco Costa, aveva raccontato, davanti a una Corte a dir poco allibita, che una mattina aveva scambiato per un colpo di Stato, la sfilata dei carri per il 4 novembre. E il presidente gli aveva chiesto testualmente: «Ma a scuola non vi avevano detto che il 4 novembre era la festa nazionale?». Si era sentito rispondere con altrettanto candore: «All’epoca leggevamo più i testi di marxismo che i testi scolastici».
Qui mi piacerebbe provare a spiegare una cosa banale, ma nemmeno troppo. Non per difendere l’utilità dei testi marxisti (cosa che comunque mi sta a cuore), ma per sgombrare il campo da un grande equivoco: in ogni tempo e luogo, le responsabilità sono sempre individuali e mai collettive. E così, malgrado le aggravanti e i condizionamenti del tempo, fare giustizia, e celebrare il processo Ramelli, voleva dire prima di ogni altra cosa, che i responsabili dell’omicidio Ramelli erano gli uomini del commando – tutti studenti universitari, e non ragazzini – che si erano dati appuntamento per flagellare un ragazzo sotto casa sua. E che era necessario capire come mai dopo poco più di dicei anni questi ex killer si presentavano davanti ai giudici immemori, ormai traslocati dentro nuove e rispettabilissime esistenze, e incapaci di spiegare la cosa più semplice, banale e necessaria: Perché? Perché mai erano arrivati a uccidere un ragazzo che nemmeno conoscevano e che, come avrebbe appurato l’inchiesta di Salvini, non aveva torto un capello a nessuno?
Anche i libri sono come maglie di una catena, che nascono uno sull’altro, e crescono insieme alle idee che custodiscono. Se qualcuno volesse continuare il filo che parte da “Una storia che fa ancora paura” e prosegue con “Cuori neri”, potrebbe aggiungere un tassello in più andando a cercare le parole che oggi gli ex ragazzi delle Hazet 36 vorrebbero e potrebbero dirci. Sul tempo che è passato, sulla colpa che hanno elaborato. Né io, né gli autori di questo libro ci siamo riusciti.
L’ultima, e forse la più importante lezione del caso Ramelli, che dovrebbe valere per tutti gli anni di piombo ha un nome, ed è quello della signora Anita. Questo libro ha avuto anche il merito, fra gli altri, di essere riuscito a far parlare la signora Anita Ramelli dopo anni di riserbo e di dolore. Il suo regalo più grande, alla memoria di questo Paese, fu quello di aver costruito in Tribunale una possibile via di uscita dalla spirale inestricabile fra l’orrore per la colpa e la tentazione delle vendetta. A cavallo fra i gradi di giudizio, infatti, furono lei e (l’allora) avvocato Ignazio La Russa, a costruire un capolavoro giudiziario ribaltando la vacuità del primo giudizio (condanna per omicidio preterintenzionale, ma con pena più severa), nell’esemplarità del secondo (condanna per omicidio volontario, ma con pena poco più che simbolica). Per loro non era importante distruggere delle vite, ma che fosse riconosciuta la violenza consapevole che aveva distrutto la vita di Sergio. Un delicato compromesso che fu reso possibile, come ricorderà poi La Russa, anche dalla disponibilità di un difensore “illuminato” come Pisapia. Eppure questa sentenza dovrebbe fare ancora oggi scuola, perché per la prima volta si metteva da parte la maledizione di Caino, e si dimostrava che la giustizia non ha bisogno di amministrare sofferenze, ma di riconoscere verità.
Se si prende tra le mani questa inchiesta, a prescindere da come la si pensi, indipendentemente se si sia di sinistra o di destra, giovani o meno giovani, si fanno tantissime altre scoperte. La più bella è sempre quella foto, e le altre che compongono questo affresco, questo viaggio intorno a una vita stroncata. Diceva Oscar Wilde: «Dopo i vent’anni ogni uomo è responsabile della faccia che si ritrova». Bene, in questo caso l’idea che anche uno sguardo possa rappresentare una rivelazione è così vera, che già a 17 anni Sergio Ramelli era responsabile di molto di più. In quell’ovale e in quei capelli lunghi e decisamente fuori norma per un ragazzo di destra (nel 1975!) quando si conosce la sua storia, si scoprono tante cose: che Sergio andò al macello con la stessa innocenza che dimostrava il suo sorriso. Che era fuori dai cliché come i suoi stessi capelli ci dicevano. Che la retorica è sempre una brutta bestia e che il rischio di apologia è sempre dietro l’angolo: ma che poi a volte è terribilmente vero, come cantava Guccini, che “gli eroi son tutti giovani e belli”. Il punto non è che li pensiamo innocenti perché sono belli. Ma che possiamo finalmente (ri)scoprire che sono davvero giovani e belli perché qualcuno o qualcosa ci ha dimostrato che non erano mostri, come aveva provato a raccontarci qualcun’altro. Ma vittime. Ciò che rende possibile tutto questo, che restituisce a uno sguardo il suo valore, e il suo senso, sono quasi sempre la scrittura, o il cinema, o la poesia. O magari, come in questo caso, una buona inchiesta.